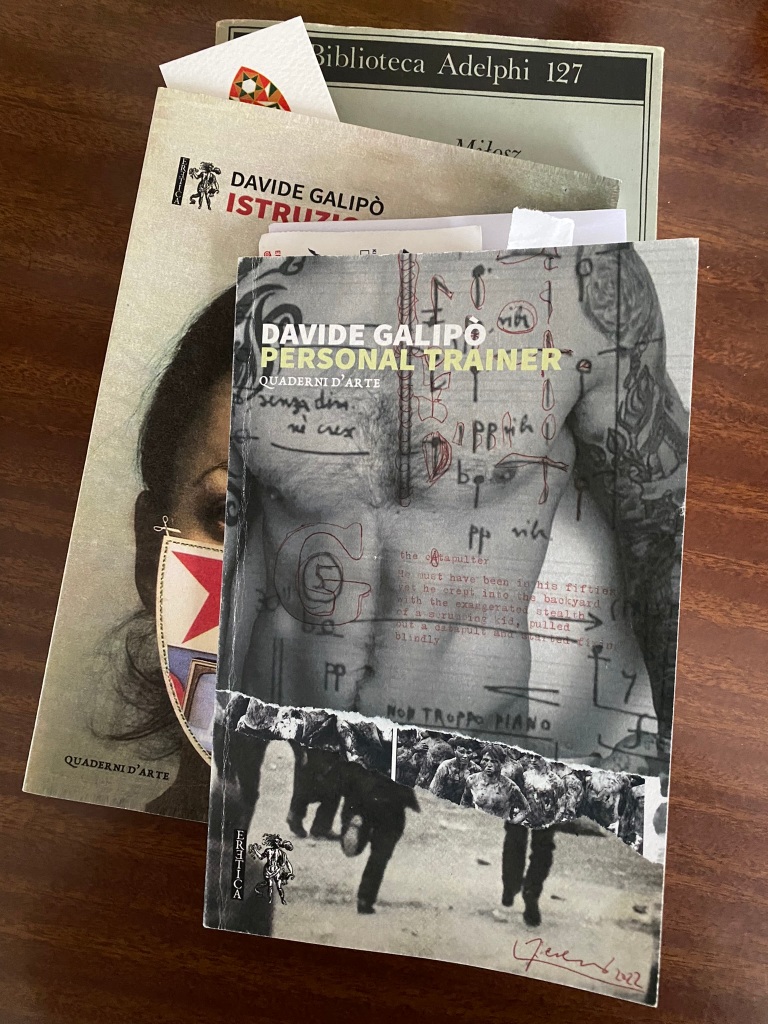È difficile invitare ad immergervi nelle pagine di questo libro senza correre il rischio di spoilerare qualcosa, togliendovi il gusto del cammino.
Quello che Mattia Corrente racconta è infatti un viaggio, una catabasi – quel viaggio negli inferi tanto caro alla letteratura greca, che ha portato Ulisse ad interrogare Tiresia, Orfeo a cercare la sua Euridice, che è diventato un topos letterario anche per la latinità con Enea che scende nell’Ade ad incontrare suo padre Anchise e per la letteratura universale, con Dante ed il suo viaggio descritto nella Divina Commedia.
Ma come tutti i grandi viaggi raccontati dai grandi libri, questo è anche un viaggio dentro sé stessi, dentro il senso più profondo del nostro essere uomini e donne, alla ricerca delle risposte alle domande più urgenti ed ineludibili che il cuore umano contiene.
A compiere il viaggio non è però questa volta un adulto “nel mezzo del cammin della sua vita”, né un eroe, almeno non come quelli che siamo stati abituati ad incontrare nella letteratura classica.
Nadia Terranova nella sua bellissima raccolta di saggi “Un’idea di infanzia. Libri, bambini e altra letteratura” ci avverte che “non esiste la letteratura ‘per’ ragazzi, esiste la letteratura con i ragazzi e bambini dentro”. Ecco, questo libro conferma assolutamente questa affermazione.
Il protagonista è un undicenne, Michele Lanza, figlio della bigliettaia degli aliscafi dell’isola di Stromboli, abitante della periferia delle periferie del mondo attuale, isolano isolato da tutti, non solo privo di superpoteri ma anche affetto da emimelia radiale, che gli blocca un braccio.
Michele non rifiuta mai una Coca cola ma la mamma non vuole che ne beva troppa, ha il cuore di burro ma pensa che solo le pappemolli piangano, soprattutto ha una curiosità che supera la paura e che lo porterà ad affrontare un viaggio assurdo ed entusiasmante, avvincente e rischioso.
Cosa ci rende uomini in fondo se non appunto l’accettare il rischio, non indietreggiare di fronte alle sfide, piccole e grandi che la vita, in maniera assolutamente imprevedibile ed a volte beffarda, ci pone di fronte?
Ci pensate mai – dice Michele ad un certo punto – a quell’attimo prima in cui sta per accadervi qualcosa che potrebbe cambiare tutto e invece potete decidere che non accadrà mai? Ecco, io adesso potrei tornarmene a casa, rimettermi il pigiama e infilarmi nel letto ancora caldo. Domattina mi alzerei come tutte le altre mattine e nessuno saprebbe cosa potevo fare e non ho fatto. Nessuno mi direbbe che sono stato un codardo perché ho lasciato perdere. Ti senti al sicuro quando puoi restare a guardare, perché tanto nessuno sa che potevi fare e non hai mosso un dito.
Ma io sono nato con una vocina dentro che mi ha sempre detto che se solo tu puoi fare una cosa, allora la devi fare.
Michele nel viaggio ha un amico speciale, un “parente di sfiga”, Gabo, il gabbiano zoppo, che incredibilmente parla (ed è pure logorroico), ed ha la zampa destra più corta della sinistra.
Due eroi “improbabili” – come li definisce il risvolto di copertina – si trovano ad affrontare un viaggio nell’aldilà protetti da alcuni dèi ma osteggiati da molti altri, per risolvere un mistero che avvolge il passato familiare di Michele ma condiziona tutto l’equilibrio del regno dell’Ade.
Se il mito è da sempre e ad ogni latitudine terrestre la narrazione di storie che sono paradigmatiche della nostra identità di uomini e donne, questo libro si pone a pieno titolo nella letteratura mitologica, reinterpretando attraverso la fantasia e soprattutto l’ironia l’equilibrio che misteriosamente lega il caso al destino, le nostre minime vicende personali, incastrate in condizioni spazio temporali che avvertiamo più come una limitazione che come uno spazio di libertà, con il senso più ampio dell’esistenza e dell’eterno scorrere del tempo.
Il mito greco rimane il punto di riferimento dell’autore, che mette sul cammino di Michele una folta schiera di divinità e figure mitologiche antiche rivisitate e reinterpretate con sagace umorismo ed efficace collegamento alla contemporaneità.
Da Demetra, dagli occhi azzurri e grandi, “la pelle rosa tipo le nuvole quando tramonta a Stromboli” e giusto qualche ruga, che cucina favolose linguine all’eoliana e calamari fritti, presentata come una mamma disperata con il desiderio di rivivere serenamente la maternità.
A Hermes, psicopompo abbronzato con i riccioli rossi, che usa lacca ecologica e si rivela un po’ imbroglione, sempre al cellulare, con ali disegnate ovunque, con i risvoltini ai pantaloni e la fobia per i germi.
A Caronte, che con l’avvento del progresso ha perso il lavoro di traghettatore d’anime ed è diventato un contrabbandiere alcolizzato, reietto come Cerbero che gli fa da compagno dopo che la tecnologia ha reso inutile anche il suo lavoro di controllore. Armato di uno speciale e strambo mattarello aiuterà Michele e, soprattutto, gli mostrerà che l’amicizia consiste nel sacrificio di sé per l’altro, e che “se vivi per volere bene a qualcuno, vale sempre la pena ricominciare anche per te”.
La fantasia spazia senza confini in questo regno dell’aldilà che è un Ade ridisegnato come un enorme mare sovrastato da un eterno tramonto, incastrato nelle viscere della terra, con delle mura di titanio a trattenerne i limiti e un arcipelago a disegnare una grande A, nelle cui isole vengono raccolti tramite un rinnovato e convincente sistema di contrappasso le anime dei defunti e le poche anime dei beati.
Un computer superintelligente ha sostituito la giustizia divina, creando caos e minando il sistema generale.
Come accade nella vita anche qui sarà attraverso una serie incredibile di incontri che i nostri eroi proveranno a risolvere un problema molto più grande di loro e delle loro energie. Incontreranno i personaggi più strani ed improbabili, dai grandi tiranni del passato – da Hitler a Nerone, da Attila a Napoleone Bonaparte – ridicolizzati e visti nella loro effimera volubilità, passando da personaggi del mito e del passato antico e recente, il pappagallo Portobello, il pirata Barbarossa a cui si è imbiancata la barba, è diventato un accumulatore seriale ed ha preso Umberto Eco come precettore, Argo, la nave che portò Giasone e gli Argonauti alla conquista del vello d’oro, che parla ed accompagna i nostri eroi nel viaggio, che conosce il futuro ma ha sempre paura di sbagliarsi, il cavallo che Caligola aveva nominato senatore. E poi la flotta degli Achei e dei Troiani, Agamennone, Leonardo Da Vinci, Alan Turing, Frida, Freddie Mercury, Diomede, Cariddi, Teti, Chirone il centauro, Eracle e persino Polifemo.
Ogni incontro – come nella vita di ognuno di noi – è un passaggio fondamentale, una possibilità che ci viene offerta per crescere e capire, mettersi in gioco e diventare grandi.
Fino a scoprire che “Gli eroi non vincono perché vincono, ma perché ci provano. Se per proteggere le persone a cui vuoi bene sei disposto a superare persino la paura di fallire.”
Perché in fondo “per diventare eroi basta avere la fortuna di volere bene a qualcuno”.